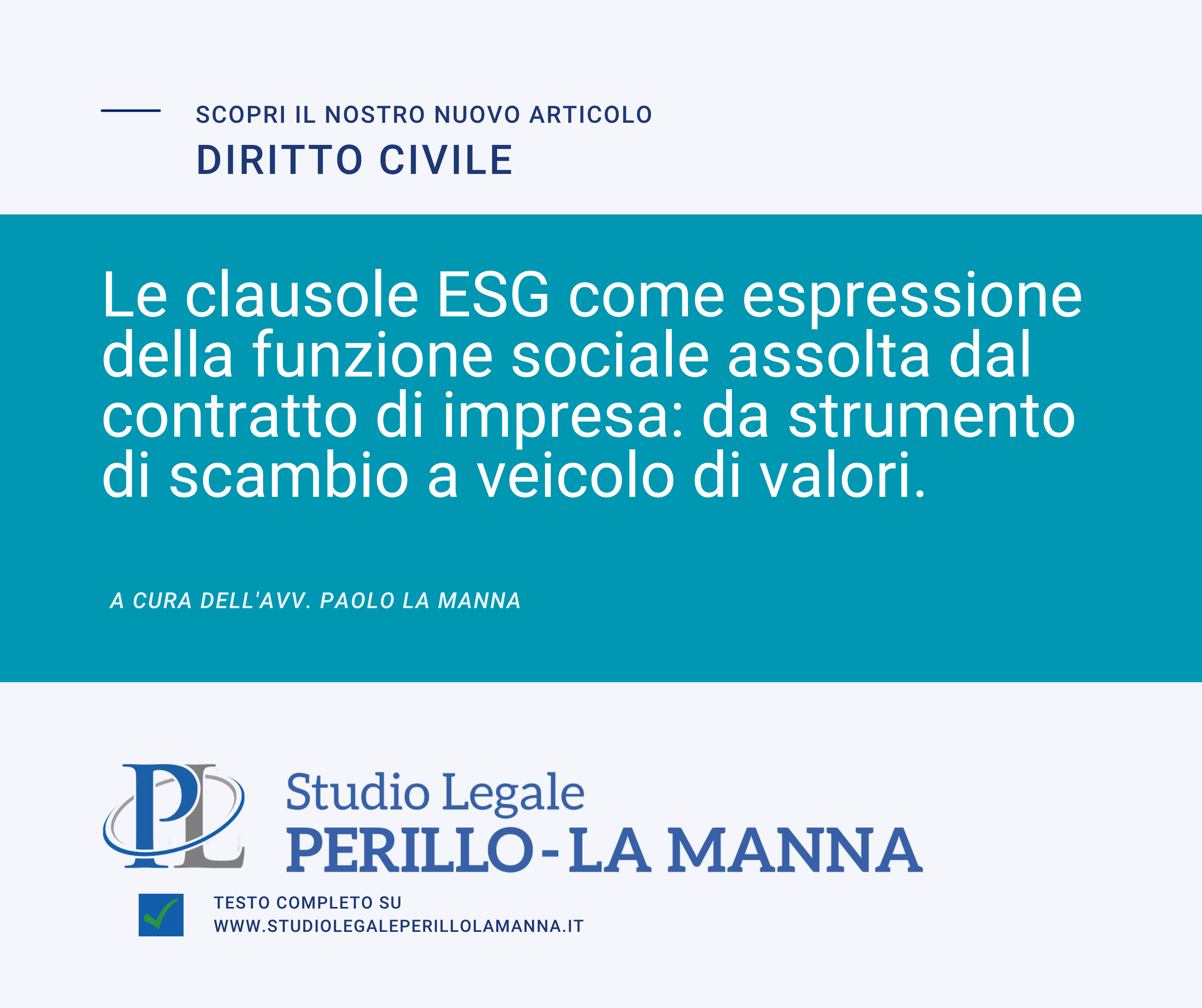
A cura dell'avv. Paolo La Manna
Il panorama giuridico ed
economico contemporaneo è permeato da una sempre più crescente ed ineludibile
attenzione verso le tematiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governance,
riassunte nell’ormai celebre acronimo ESG (Environmental, Social, Governance).
Tale sensibilità,
originariamente confinata in ambiti di soft law o di corporate social
responsibility, ha progressivamente acquisito una cogenza giuridica, anche
in forza di un imponente corpo normativo di matrice europea.
Basti pensare al Regolamento
(UE) 2019/2088 (SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation)
che
ha quale obiettivo una maggiore trasparenza nel settore finanziario in merito
all’integrazione di fattori ambientali, sociali e di governance, oppure alla
Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD - Corporate Sustainability Reporting
Directive) – che impone obblighi di trasparenza e di rendicontazione non
finanziaria, recepita nell’ordinamento interno con il D. Lgs. 6 settembre 2024,
n. 125.
L’attuale transizione
ordinamentale verso un’economia sostenibile sta progressivamente ed inevitabilmente
riverberando i propri effetti anche sulla grammatica del diritto contrattuale. Si
direbbe che gli schemi negoziali tra imprese, tradizionalmente incentrati sulla
sinallagmaticità delle prestazioni a contenuto patrimoniale, vadano oggi
arricchendosi di nuove dimensioni valoriali, rimaste, in precedenza,
inesplorate o, comunque, per lo più relegate ai margini del diritto positivo.
L’autonomia privata
codicistica, motore primo delle relazioni commerciali (art. 1322 c.c.), assurge,
oggi, a strumento privilegiato per la promozione di condotte responsabili,
divenendo il luogo elettivo per la traduzione di principi etici in obbligazioni
giuridicamente vincolanti. È in questo fertile terreno che possono germinare e diffondersi
le clausole ESG che, se correttamente strutturate, sono potenzialmente idonee a
costituire manifestazioni di una volontà negoziale che trascende il mero
scambio economico per abbracciare una finalità etica di più ampio respiro.
Volendo provare ad individuare
una definizione pertinente alle clausole ESG, potremmo dire che esse possono essere
intese come pattuizioni contrattuali mediante le quali le parti si
obbligano, reciprocamente o unilateralmente, a rispettare specifiche regole
etiche e/o di sostenibilità che le aziende possono decidere di perseguire
nell’esercizio della propria attività, ovvero a compiere azioni positive volte
a promuovere tali valori nell’esecuzione del rapporto.
Esse non rappresentano altro
che l’incorporazione, all’interno del tessuto del contratto, di parametri di
condotta che attingono a fonti eterogenee. Sotto il profilo genetico, infatti, è
possibile operare una distinzione tra clausole di fonte unilaterale, spesso
inserite in condizioni generali di contratto o in codici di condotta del
committente, cui il fornitore o partner commerciale è tenuto ad aderire; clausole
di fonte bilaterale, frutto della negoziazione tra le parti, che
definiscono di comune accordo - con evidente maggiore equilibrio e maggiore
adesione agli obiettivi prefissati - i reciproci impegni di sostenibilità,
modulandoli secondo le specificità del rapporto; clausole derivanti da
standard di settore, ovvero disposizioni che fanno rinvio a fonti esterne,
quali normative tecniche. Si pensi, a titolo di esempio, alle certificazioni
ISO 14001, una norma internazionale che specifica i requisiti per un sistema di
gestione ambientale, oppure convenzioni internazionali (ad esempio, agli standard
ILO in materia di lavoro) o principi di autodisciplina. Tale tecnica del rinvio
- per relationem - consente di dotare il precetto contrattuale di un
elevato grado di specificità e verificabilità.
Ciò senza dimenticare che la
loro efficacia e interpretazione sono sempre e comunque presidiate dai canoni
generali della buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) e dell’equità contrattuale.
La buona fede oggettiva, in particolare, opera, come noto, come criterio di
integrazione del contenuto contrattuale, imponendo alle parti un dovere di
leale cooperazione per la realizzazione non solo degli interessi economici, ma
anche degli obiettivi di sostenibilità formalizzati nel negozio.
La casistica delle clausole
ESG è ampia e in costante evoluzione, adattandosi alla varietà dei settori
produttivi e degli obiettivi perseguiti. Non può, pertanto, essere
esaustivamente passata in rassegna. Tuttavia, in ambito contrattuale, un
esempio di prassi può essere costituito dalle previsioni talvolta inserite nei contratti
di fornitura a lungo termine (long-term supply agreements), nelle
quali si richiede al fornitore di adottare sistemi di gestione ambientale
certificati (ad esempio secondo lo standard ISO 14001), oppure di rispettare
stringenti obblighi in materia di diritti umani e condizioni di lavoro
dignitose, nonché di accettare necessari meccanismi di verifica e controllo da
parte della controparte.
Tali clausole, peraltro,
possono prevedere espressamente la qualificazione del loro inadempimento come
violazione grave, suscettibile di determinare la risoluzione del contratto
per giusta causa, ai sensi dell’art. 1453 c.c., con facoltà di richiedere
il risarcimento del danno ulteriore.
In altri e diversi ambiti
contrattuali, come nel caso di appalto per servizi, invece, soprattutto
se di durata pluriennale e relativi ad attività a rilevante ed elevato impatto
ambientale o sociale (si pensi, ad esempio, a contratti di manutenzione di
impianti, gestione rifiuti o servizi energetici), è sempre più frequente – nonché
auspicabile - l’inserimento di clausole ESG che impongano all’appaltatore il
rispetto di determinati standard di sostenibilità ambientale e di
responsabilità sociale.
Tali previsioni contrattuali
possono comprendere, tra l’altro, l’obbligo di utilizzare materiali a basso
impatto ambientale, la preferenza per subappaltatori e fornitori certificati
secondo standard ESG riconosciuti, la tracciabilità dei flussi di smaltimento,
così come l’impegno a garantire la parità di genere e l’inclusione lavorativa
nelle politiche aziendali.
Anche in questo caso, la
clausola deve essere generalmente strutturata in modo da prevedere un sistema
di audit, la segnalazione di eventuali violazioni e un termine per la loro
rimozione. Il persistere dell’inadempimento comporta, di norma, la possibilità
per il committente di risolvere il contratto in via anticipata per giusta
causa, con ogni conseguenza risarcitoria.
Altre
pattuizioni frequentemente utilizzate includono l’obbligo di rendicontazione
periodica, quindi l’impegno a fornire report dettagliati sui consumi
energetici, sulle emissioni di gas serra o su indicatori sociali (tra questi,
ad esempio, il gender pay gap o i tassi di infortunio), le clausole “code
of conduct” per la filiera, quindi l’obbligo per il fornitore di imporre i
medesimi standard ESG ai propri sub-fornitori, creando un effetto a cascata di
responsabilità lungo l’intera supply chain. Sul fronte rimediale, non è rara la
previsione di penali per inadempimento. Si tratta, in effettivi, di specifiche
penali pecuniarie, come previste dall’art. 1382 c.c., commisurate alla gravità
della violazione di determinati parametri ESG, che devono essere, naturalmente,
chiari, misurabili e oggettivamente verificabili, anche ai fini della
valutazione di congruità della penale.
L’impiego delle clausole ESG,
tuttavia, non è esente da criticità. Il rischio principale, ampiamente noto, è
costituito dal fenomeno del greenwashing, ovvero l’utilizzo di
affermazioni di sostenibilità generiche e non verificabili a meri fini
reputazionali, senza un reale impegno sostanziale. Per scongiurare tale
pericolo, è imprescindibile che le clausole siano formulate quanto meno con un
elevato grado di precisione, prevedendo, in maniera stringente, la presenza di
indicatori di performance (KPI) misurabili e meccanismi di monitoraggio,
audit e sanzione efficaci.
Emerge, inoltre, la necessità
di un delicato bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica (art. 41
Cost.) e la responsabilità sociale d’impresa, che trova oggi un implicito
riconoscimento costituzionale nella tutela dell’ambiente, della biodiversità e
degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni (art. 9 Cost.).
Le clausole ESG rappresentano uno degli strumenti attraverso cui l’autonomia
privata si fa carico di questa responsabilità, orientando l’esercizio dell’attività
d’impresa verso scopi che trascendono il profitto individuale.
In una prospettiva
sistematica, tali pattuizioni potrebbero essere lette come una moderna
espressione della “funzione sociale” della proprietà e, per analogia, del
contratto. Se il contratto è lo strumento per eccellenza della circolazione
della ricchezza, l’inserimento di vincoli ESG ne conforma l’esercizio a valori
di utilità sociale, spingendo l’autonomia negoziale a contribuire positivamente
al benessere della collettività e alla salvaguardia del creato.
Orbene, l’analisi delle
clausole ESG sin qui svolta invita ad una riflessione che travalica i confini
del diritto positivo per attingere a una dimensione etica.
Difatti, i principi che esse
veicolano – tutela ambientale, dignità del lavoro, equità sociale – risuonano
con particolare vigore se letti – liberamente, si intende - alla luce di un
orizzonte di valori più ampio.
Encicliche come la Caritas
in Veritate di Benedetto XVI e la Laudato si’ di Papa Francesco
offrono una cornice concettuale di straordinaria pertinenza. Esse richiamano a
un’ecologia integrale, in cui la “cura della casa comune” è
inscindibilmente legata alla giustizia per i poveri e al rispetto della dignità
inalienabile di ogni persona umana: “vivere la vocazione di
essere custodi dell’opera di Dio è parte essenziale di un’esistenza virtuosa,
non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto secondario
dell’esperienza cristiana” (ivi, 217).
Il contratto, in questa
visione, cessa di essere unicamente un’arena di interessi contrapposti per
divenire un luogo di “comunione d’intenti”. Esso può così trasformarsi in uno
strumento che, oltre a realizzare gli interessi economici delle parti, concorre
attivamente alla costruzione del bene comune.
La responsabilità dell’impresa e, di riflesso, del giurista che ne assiste l’operato, in tal modo si espande. Non si tratta più, nel contesto attuale, di garantire esclusivamente la validità formale e l’efficacia sinallagmatica del negozio, ma di promuovere una contrattualistica evoluta, capace di farsi interprete delle sfide del nostro tempo. Il giurista è dunque chiamato a essere un “architetto” di relazioni contrattuali che siano non solo economicamente efficienti, ma anche giuridicamente solide ed eticamente responsabili, orientando l’autonomia privata verso quell’orizzonte di sostenibilità integrale che costituisce, oggi più che mai, un imperativo giuridico ed etico.