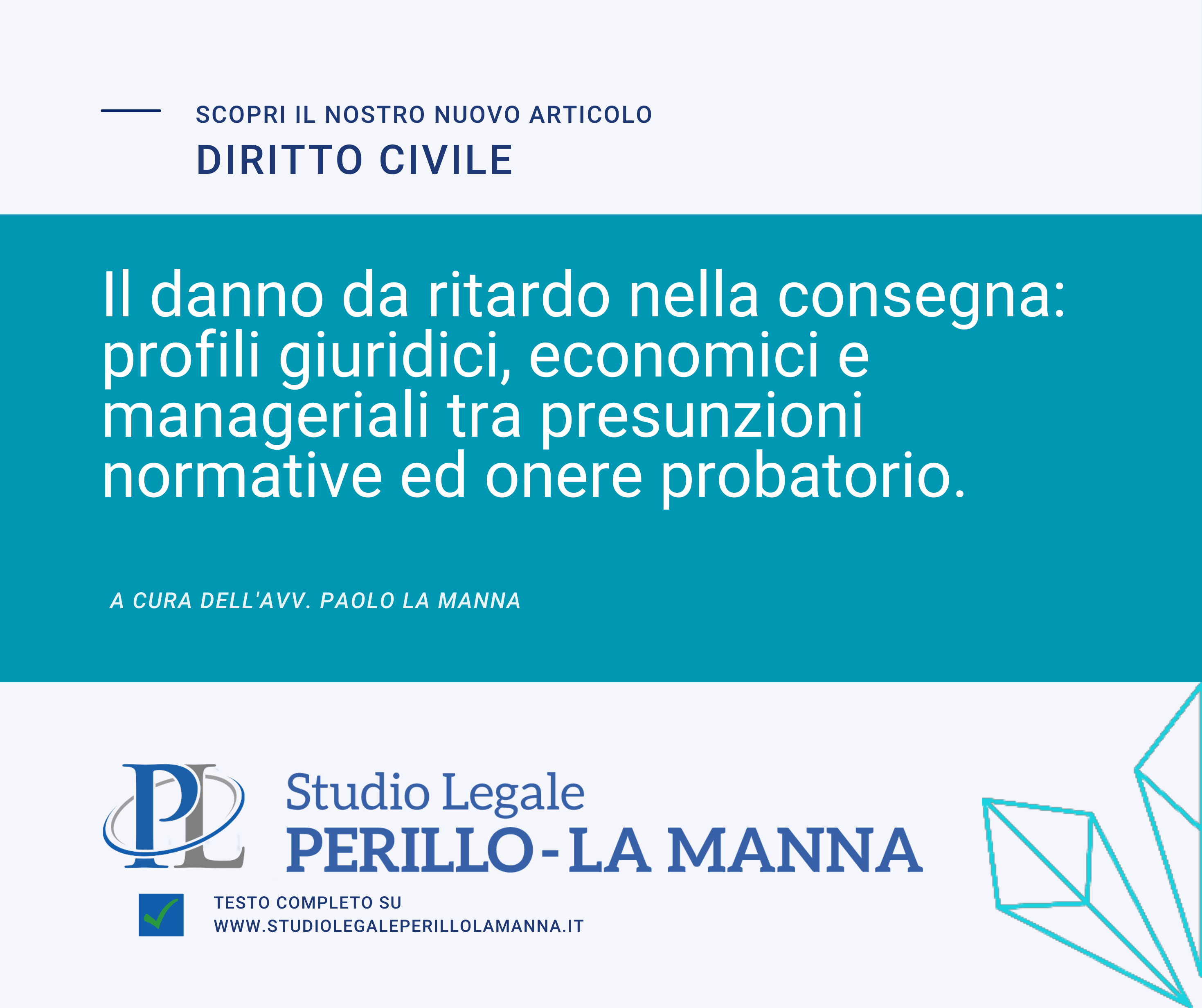
A cura dell'avv. Paolo La Manna
La tematica del risarcimento
del danno conseguente al ritardo nella consegna delle merci costituisce una
questione giuridica complessa e di rilevante impatto economico e gestionale,
idonea a stimolare un’indagine che valorizzi l’interazione tra diritto,
economia e management.
Occorre evidenziare, in primo
luogo, che dal punto di vista normativo, il quadro regolatore si articola
attorno alla distinzione tra la disciplina speciale prevista dall’art. 1518 c.c.
e quella generale di cui all’art. 1223 c.c. Secondo consolidata giurisprudenza
della Suprema Corte, l’art. 1518 c.c. stabilisce un meccanismo di liquidazione
del danno applicabile esclusivamente ai casi di risoluzione contrattuale per
inadempimento, laddove la merce abbia un prezzo corrente (Cass. civ., Sez. II,
sentenza n. 11126 del 2022). Tale norma, essendo di carattere eccezionale, non
è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica ai casi di mero
ritardo, con la conseguenza che, in tali ipotesi, trova piena applicazione l’art.
1223 c.c., il quale impone al creditore l’onere di dimostrare l’entità del
danno subito e il necessario nesso di causalità con il ritardo nella consegna.
La giurisprudenza ha inoltre
chiarito che la prova del danno emergente può basarsi su criteri presuntivi,
purché fondati su elementi indiziari adeguatamente precisi e concordanti (Cass.
civ., Sez. II, sentenza n. 19073 del 2021). Tra questi, particolare rilievo
assume la documentazione commerciale: fatture, contratti di vendita e documenti
di trasporto possono concorrere alla dimostrazione del danno, acquisendo un
valore strategico nella gestione del rischio aziendale e nella tutela delle
pretese risarcitorie.
Non può escludersi dalla trattazione
il cd. “termine essenziale”, disciplinato dall’art. 1457 c.c., che rappresenta
un elemento fondamentale nella valutazione dell’inadempimento per ritardo. Si
configura quando l’osservanza del termine costituisce elemento determinante per
l’interesse del creditore, tanto che il suo mancato rispetto comporta
automaticamente la risoluzione del contratto, salvo che il creditore, entro tre
giorni, comunichi di voler comunque ricevere la prestazione. La natura
essenziale del termine può derivare sia da un’espressa pattuizione delle parti
(termine essenziale in senso soggettivo) sia dalla natura stessa dell’affare
(termine essenziale in senso oggettivo), quando cioè la prestazione, se
eseguita successivamente, risulterebbe oggettivamente inidonea a soddisfare l’interesse
del creditore. Esempi tipici si riscontrano nella compravendita di beni
deperibili, nelle forniture per eventi temporalmente definiti o nelle
prestazioni la cui utilità è intrinsecamente legata a una precisa collocazione
temporale.
Come contraltare dell’essenzialità
del termine, vi è la valutazione della tollerabilità del ritardo che richiede un’analisi
contestuale che tenga conto di molteplici fattori: le prassi commerciali
consolidate nel settore merceologico di riferimento, la natura della
prestazione, l’interesse specifico del creditore e le circostanze concrete dell’esecuzione.
Mentre in alcuni ambiti commerciali possono essere considerati fisiologici
lievi scostamenti temporali, in altri settori anche ritardi minimi possono
configurare un inadempimento grave ai sensi dell’art. 1455 c.c., tale da
giustificare la risoluzione del contratto. Questo accade, ad esempio, nelle
forniture destinate a campagne promozionali temporalmente definite o a eventi
stagionali, dove la tempestività dell’adempimento è intrinsecamente connessa
all’utilità della prestazione. L’analisi della tollerabilità del ritardo deve
quindi essere condotta caso per caso, considerando non solo gli usi commerciali
ma anche l’impatto concreto del ritardo sull’economia complessiva del contratto
e sulla realizzabilità dell’interesse del creditore. In questo contesto, assume
particolare rilevanza anche la buona fede nell’esecuzione del contratto ex art.
1375 c.c., che impone di valutare il comportamento di entrambe le parti nella
gestione delle tempistiche contrattuali.
Infine, sotto il profilo
delle strategie aziendali, la comunicazione tempestiva e trasparente tra le
parti contrattuali rappresenta un elemento determinante per la prevenzione dei
conflitti e per la risoluzione extragiudiziale delle controversie. Una gestione
efficace delle relazioni commerciali, unita a una chiara allocazione delle
responsabilità, può ridurre il rischio di contenziosi e salvaguardare la
continuità dei rapporti d’affari.
In definitiva, il tema del risarcimento del danno da ritardo nella consegna delle merci si colloca al crocevia tra diritto, economia e management, richiedendo un approccio integrato e multidisciplinare. Solo attraverso una sinergia tra competenze giuridiche, strategia aziendale e strumenti tecnologici avanzati è possibile garantire una tutela effettiva degli interessi in gioco e una gestione proattiva delle criticità legate alle transazioni commerciali.