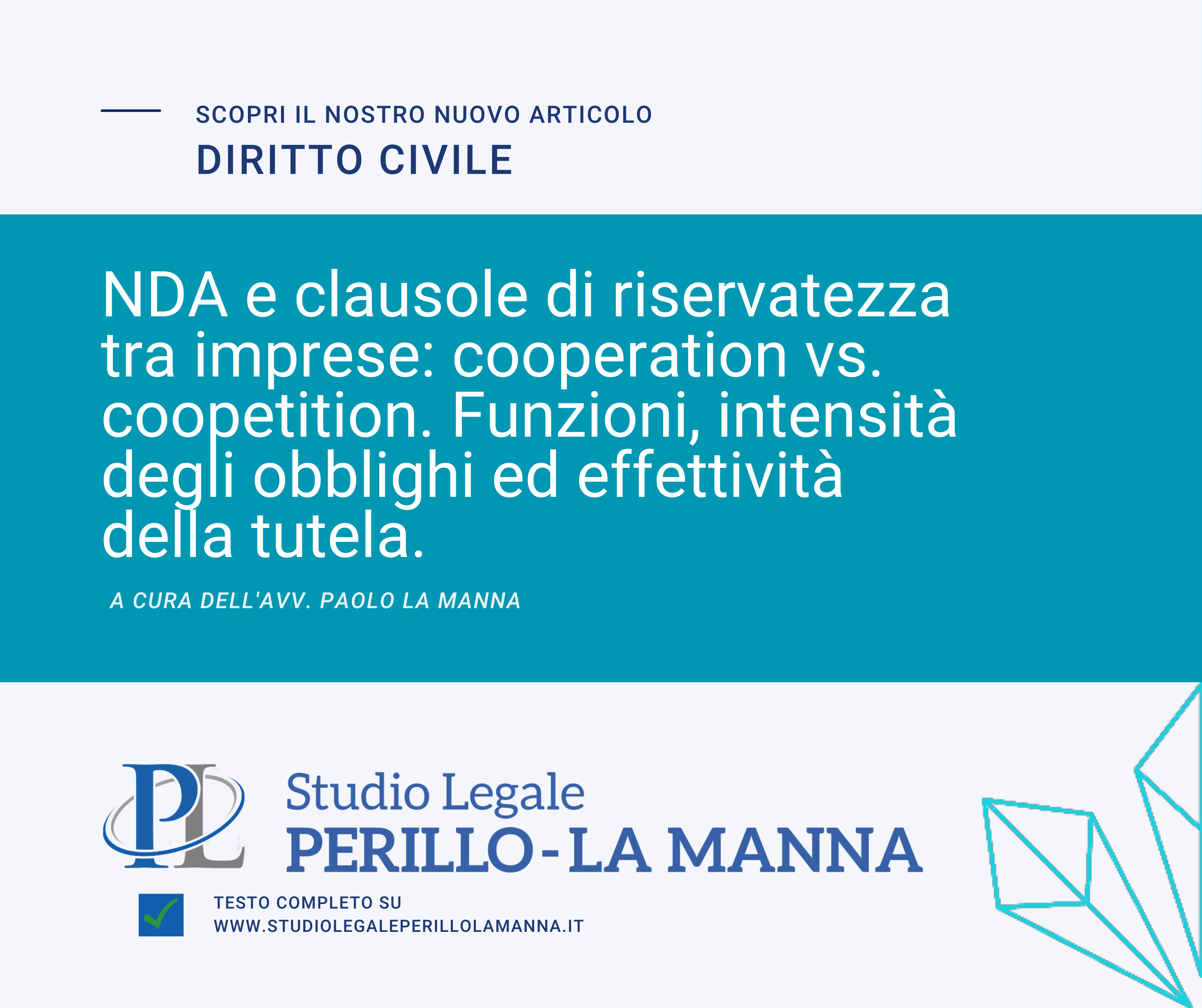
A cura dell'avv. Paolo La Manna
1. Premessa
Nel contesto del commercio internazionale, in cui gli operatori economici
stabiliscono rapporti complessi, lo scambio di informazioni di natura
confidenziale è una pratica molto diffusa. Questo è particolarmente
evidente durante le fasi di valutazione e studio di potenziali collaborazioni
commerciali, come contratti di trasferimento di tecnologia o di know-how, joint
venture, fusioni o acquisizioni societarie.
In queste situazioni, le parti coinvolte necessitano di condividere
informazioni riservate riguardanti aspetti progettuali, produttivi,
commerciali, finanziari e strategici.
Sebbene ogni sistema giuridico fornisca una protezione normativa di base
per la riservatezza di tali informazioni, è prassi comune integrare tali
protezioni con strumenti negoziali, come accordi di riservatezza noti anche
come "Non Disclosure Agreements" (NDA) o "Confidentiality
Agreements".
2. Cooperation or co-opetition?
È utile, a questo punto, una breve digressione sull’ancora più spiccato
valore che tali accordi assumono in caso di imprese che sposino meccanismi
di co-opetition e non di semplice cooperazione. La cd. co-opetition altro
non è che una strategia di tipo competitivo-cooperativo tra due o più imprese
concorrenti, che collaborano per realizzare congiuntamente una o più fasi di
produzioni di un determinato bene e/o servizio.
Tuttavia, si tratta di una forma di cooperazione tra aziende
concorrenti, particolarmente fruttuosa per aziende innovative, che si
differenzia per alcuni aspetti sostanziali dai tradizionali accordi di
cooperazione che, spesso, anche in caso di aziende con business di
profilo elevato, falliscono miseramente: ciò accade perché le parti
interessate partono dalla condizione di fondo che il successo di una debba
andare a discapito dell’altra, una situazione nella quale la contrapposizione
tra le parti è totale e la vincita dell’una corrisponde alla perdita
dell’altra.
Al contrario, la co-opetition rappresenta un tipo di collaborazione
in cui due aziende concorrenti uniscono le proprie forze sulla base di una
parziale congruenza di interessi: “quando due business agiscono
basandosi su questo tipo di presupposti hanno la possibilità di diventare più
competitivi cooperando” (Adam M. Brandbenburger e Barry J. Nalebuff, Yale
and Harvard University).
La co-opetition si basa sul tener conto sia dell’interesse
della propria impresa sia di quello dell’altra impresa coinvolta: c’è quindi
trasparenza sulle motivazioni, gli obiettivi e le future mosse di entrambe le
aziende. Mentre nella collaborazione tradizionale la domanda che ci si pone è
come sommare il proprio risultato di impresa e quello altrui, nella co-opetition ci
si prefigge di raggiungere un risultato che, ancorché vantaggioso per entrambe
le parti, generi un valore molto più ampio della semplice somma di risultati.
La co-opetition funziona particolarmente bene con imprese che
lavorano sulla tecnologia e l’innovazione, con elevati investimenti di R&D.
Valga come esempio la collaborazione tra American Airlines e Boeing che ha
consentito di unire risorse finanziarie e manodopera per dare il via alla nuova
generazione di aerei appartenenti al progetto “76 Next Generation 737s”.
Le diverse sfaccettature e le varie potenzialità della co-opetition emergono
in modo evidente prendendo in considerazione un’altra celebre vicenda: la
fornitura da parte di Samsung del nuovo ed innovativo schermo curvo Oled alla
concorrente Apple per il suo iPhone X. Samsung, naturalmente, non fornendo ad
Apple il proprio avanzato schermo avrebbe potuto intaccarne la leadership nel
mercato degli smartphone premium, nel quale si trovano in competizione proprio
il Samsung Galaxy e l’Apple iPhone. Però, ove Samsung non si fosse dimostrata
disponibile a fornirle lo schermo Oled, certamente Apple si sarebbe rivolta ad
altri operatori del comparto, ad esempio LG (che ha prodotto gli schermi Oled
per i telefoni Pixel 3 di Google) oppure Boe (che ha fornito schermi Oled per i
telefoni Mate 20 Pro di Huawei). Teniamo conto anche che Apple, notoriamente,
adotta la politica di dare un fattivo supporto ai propri fornitori, al fine di
consentirne un rapido miglioramento in termini di efficienza e qualità.
Samsung, dunque, ha deciso di collaborare con la competitor Apple, non solo per
i notevoli benefici che ne sarebbero derivati in termini di fatturato, ma anche
– e, probabilmente, soprattutto – per non determinare un rafforzamento dei suoi
concorrenti ed un inevitabile assottigliarsi del proprio vantaggio competitivo.
3. La funzione degli NDA e delle clausole di riservatezza
Ritornando al tema principale della presente disamina, occorre evidenziare
che, talvolta, al fine di disciplinare la condivisione di informazioni
riservate, non si parla di autonomi accordi di segretezza previ rispetto alla
conclusione del contratto cui essi sono preordinati, ma di singole clausole di
riservatezza, inserite in contratti conclusi e pienamente operativi, o anche
atte a disciplinare, con il carattere dell’ultrattività, la fase successiva
all’estinzione del contratto.
La natura stessa degli accordi e dei diritti, morali e patrimoniali, cui
gli accordi di riservatezza sono posti a presidio, evidenzia chiaramente che
essi sono finalizzati a conseguire due obiettivi principali:
Vi sono molteplici circostanze in cui l’utilizzo di clausole di
riservatezza si rivela indispensabile ed ineludibile, in relazione agli
obiettivi ed alle finalità che tali clausole intendono conseguire.
Tra queste:
4. Cenni normativi
ed eccezioni.
Orbene, gli Accordi di Non Divulgazione (NDA) sono comunemente utilizzati
nei trasferimenti di tecnologia, negli accordi di licenza di brevetti e nelle
acquisizioni di partecipazioni societarie. Questi accordi sono
stipulati in fasi preliminari rispetto a un possibile accordo futuro.
Tuttavia, per valutare la fattibilità e la convenienza di tali contratti, è
spesso necessario uno scambio informativo, che può essere coperto da un NDA.
Questo tipo di accordo cade nelle fasi iniziali delle trattative, in cui non
sono ancora stati stabiliti contatti sociali significativi tra le parti.
L’NDA - ove sottoscritto - è un contratto a tutti gli effetti, atipico
e con effetti obbligatori, giuridicamente vincolante fra soggetti giuridici che
– nell’ambito di trattative precontrattuali o nella vigenza di rapporti
contrattualmente già disciplinati - convengono espressamente che
determinate informazioni confidenziali che condividono debbano rimanere
riservate e non possano essere utilizzate per scopi e/o secondo modalità
diverse da quelle concordate.
La disciplina di riferimento, quanto all’ordinamento giuridico italiano, è
il principio di correttezza e buona fede cui devono essere
generalmente improntati i rapporti contrattuali (art. 1337 c.c., art. 1366
c.c., 1375 c.c.) e la condotta da tenersi in genere nell’adempimento delle
obbligazioni (art. 1175 c.c.), secondo il quale esiste un generale dovere
di correttezza e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti giuridici, che si
sostanzia nell’obbligo per i contraenti di mantenere un comportamento
oggettivamente ispirato a tali valori nei momenti fisiologici dell’atto
negoziale.
Le clausole di riservatezza, invece, sono incluse nei
documenti contrattuali e possono essere regolate in diverse fasi
temporali: lettere d’intenti, contratti conclusi e fasi successive
all’esecuzione del contratto.
Nel tempo la dottrina si è confrontata su quale fosse, tuttavia, la reale
intensità degli obblighi di riservatezza, in base alla distinzione tipica dei
sistemi di civil law tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni
di risultato.
Sorge, dunque, l'interrogativo se il soggetto vincolato da un impegno di
riservatezza debba limitarsi a compiere il massimo sforzo possibile, secondo il
principio del “best effort”, e, di conseguenza, essere tenuto a
rispettare gli standard di diligenza ordinaria. Oppure, se l'obbligo in
questione debba assumere una connotazione più rigorosa e categorica,
caratterizzandosi sostanzialmente per una natura assoluta e oggettiva, con la
responsabilità che si manifesta indipendentemente da qualsiasi negligenza
imputabile al custode della “non divulgazione”.
Naturalmente, la disciplina della riservatezza prevede che vi siano delle
eccezioni alla tutela che siano di carattere soggettivo, relative
ai soggetti che devono necessariamente entrare in possesso delle informazioni
riservate per garantire funzionalità stessa dell’operazione contrattuale,
nonché di carattere oggettivo relative alle i) informazioni di
dominio pubblico; ii) informazioni che la controparte già possedeva per conto
proprio (in relazioni alle quali, in casi selezionati, a fini preventivi di
controversia, può rivelarsi utile provvedere al deposito fiduciario cd. “escrow”
presso un notaio); iii) informazioni che la parte riceva da un terzo.
5. Conclusioni
Al di là di ciò, a dispetto della fondamentale rilevanza di accordi e clausole idonei a dar luogo a rapporti imprenditoriali ad alto valore, già a partire dalla fase precontrattuale e dedicata alla negoziazione ed allo scambio di informazioni, non può tacersi che nella prassi operativa si incontrano spesso previsioni contrattuali estremamente deboli, al punto da poterle considerare prive di qualsivoglia reale efficacia; risulta, invece, di fondamentale importanza la previsione di un adeguato apparato sanzionatorio e rimediale che tenga conto della tutela che necessitano entrambe le parti del negozio giuridico, sempre nell’alveo di una relazione giuridica sana che tenda alla realizzazione di operazioni win-win, ancora meglio se orientate alla co-opetition piuttosto che alla semplice cooperazione.