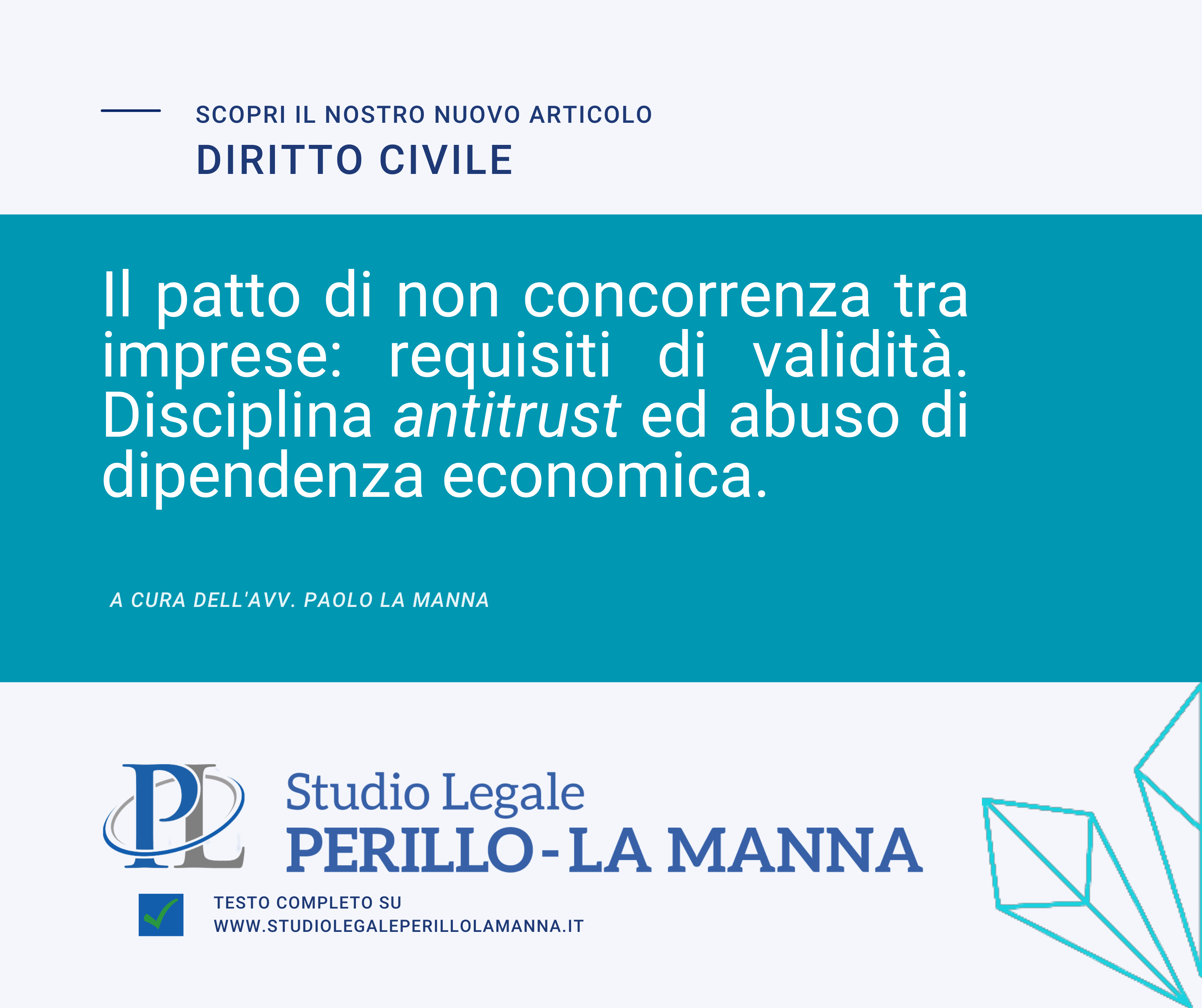
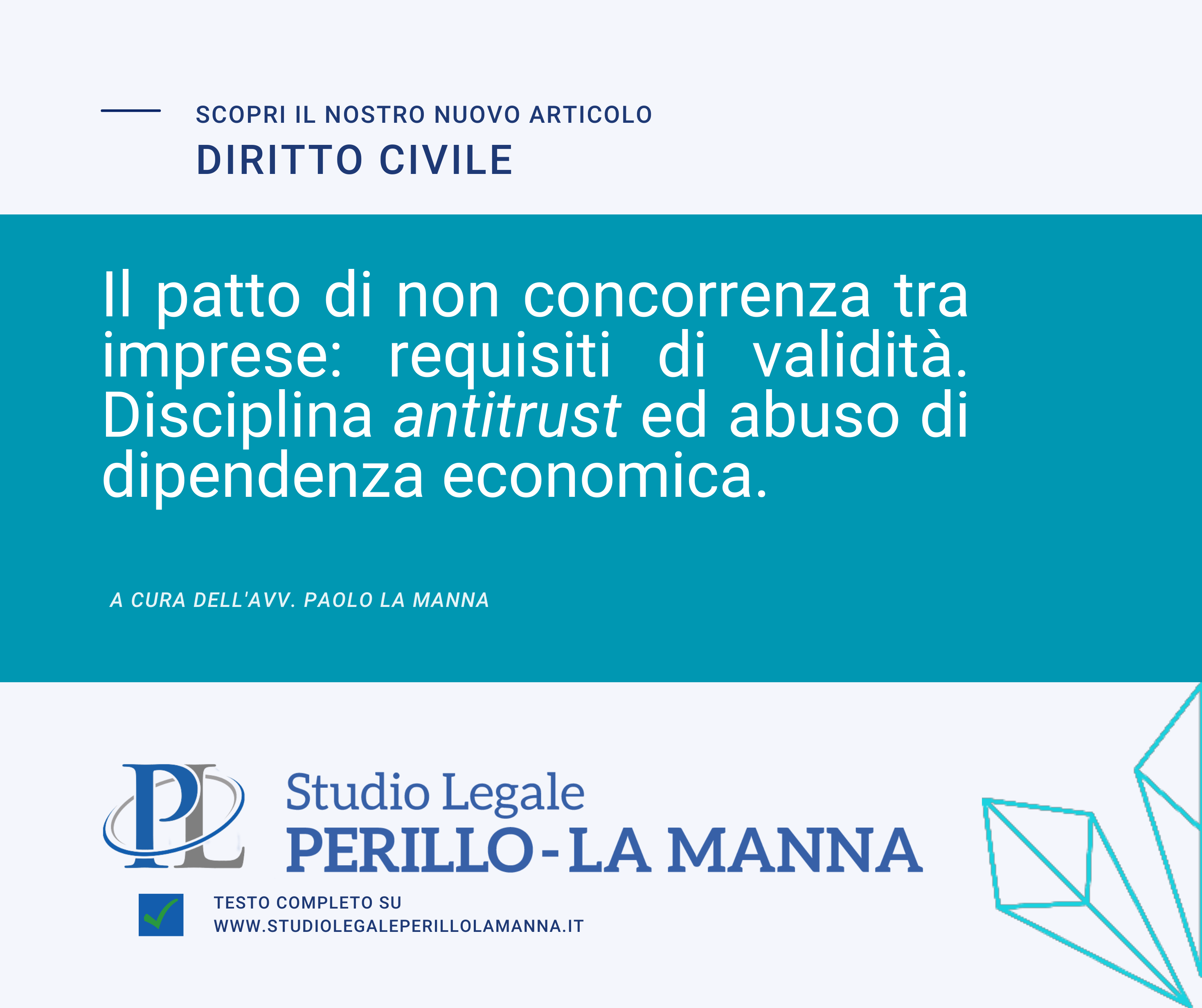
A cura dell'avv. Paolo La Manna
L’art. 2595 c.c. stabilisce
il principio generale secondo cui “la concorrenza deve svolgersi in modo da
non ledere gli interessi dell’economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla
legge”.
La “concorrenza”, termine
diffuso nelle scienze economiche che non si sottrae all’interpretazione
giuridica, implica, come noto, una competizione tra soggetti che condividono un
obiettivo che non tutti possono conseguire in egual misura. Una competizione che
si verifica in definiti contesti di risorse scarse, in cui molteplici operatori
economici si fronteggiano per conseguire la maggior parte delle risorse disponibili
o, quanto meno, quella parte delle risorse idonea ad esaurire le proprie
capacità produttive.
Tuttavia, tale competizione,
i cui frutti - quando sana e conforme ai principi di legge - non solo
concorrono allo sviluppo economico ma anche al progresso sociale, deve
svolgersi “nei limiti stabiliti dalla legge”.
Tra i limiti di legge, vi sono
sicuramente quelli previsti e stabiliti dall’art. 2596 c.c. in merito alla
formazione di regolamenti negoziali tra imprese che abbiano effettivi restrittivi
della concorrenza: “il patto che limita la concorrenza deve essere provato
per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una
determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni”.
Da ciò si desume
immediatamente che il patto di non concorrenza:
§ è sottoposto
alla forma scritta ad probationem, sebbene giurisprudenza più risalente,
in caso di contratto di vendita o somministrazione per i quali non sia richiesta
la forma scritta, atteso il principio generale della libertà delle forme,
stabilisce che la clausola resti sottoposta solo alla medesima disciplina
formale del contratto nel suo complesso; è del tutto pacifico, invece, che
il patto di non concorrenza debba essere specificamente approvato per iscritto
dall’altra parte quando contenuto in moduli, formulari o condizioni generali di
contratto di formazione unilaterale, secondo quanto previsto dall’art. 1341,
comma 2, c.c.;
§ è
valido se circoscritto ad una determinata area territoriale o circoscritto
a specifiche attività o settori di produzione, dovendo quindi avere i
requisiti della determinatezza geografica e merceologica;
§ è efficace
per un arco temporale massimo di cinque anni.
Sebbene tali requisiti siano
stati ampiamente dibattuti dalla dottrina e rielaborati dalla giurisprudenza
secondo molteplici orientamenti che non potranno essere discussi in questa sede,
può dirsi, in via generale, che l’art. 2596 c.c. disciplina le limitazioni
della concorrenza pattuite tramite accordi convenzionali, che possono vietare a
qualcuno di competere o imporgli di farlo secondo determinate modalità. Si
tratta, quindi, di limitazioni che si basano sulla volontà dei contraenti di
non esercitare la propria libertà di iniziativa economica, secondo determinate regole
pattuite.
I "patti che limitano
la concorrenza", dunque, sono accordi che circoscrivono la libertà di
negoziazione dei contraenti. Tali accordi riducono i margini di concorrenza,
riducendo la libertà di iniziativa economica. Si tratta di limitazioni della
competizione che si basano sulla restrizione della volontà, impedendo certi
atti o imponendo altri.
Si tratta, in effetti, di
accordi che regolano il rapporto tra l’autonomia individuale degli operatori
economici ed il mercato stesso, in rapporto di stretta interconnessione,
giacché il mercato dipende dall'autonomia individuale e i vincoli
all'autonomia influenzano inevitabilmente il funzionamento del mercato. La
norma sui patti di non concorrenza riconosce, da un lato, l'ampiezza dell’autonomia
privata, compresa la libertà di iniziativa economica, ma allo stesso tempo
protegge tale libertà limitandola parzialmente.
Anteposta questa doverosa
premessa, è bene chiarire che i privati possono sì restringere la libertà
negoziale, ma non eliminarla del tutto. Difatti, la regola sui patti di non
concorrenza si aggiunge ad altre norme del codice civile che stabiliscono “limiti
alle limitazioni”, impedendo a qualcuno di rinunciare completamente
all’attività economica, anche a fronte di un compenso. Ciò nel solco dell’art.
1322, comma 1, c.c. il quale nel riconoscere alle parti di determinare
liberamente il contenuto del contratto, evidenzia che ciò debba comunque avvenire
secondo “i limiti imposti dalla legge”.
La disciplina codicistica, sin
qui sinteticamente descritta, non può non tener conto dalla normativa sull’abuso
di dipendenza economica, nonché della normativa antitrust interna ed
europea, con particolare riferimento all’art. 2, l. 10 ottobre 1990, n. 287
(c.d. legge antitrust) ed all’art. 101 TFUE (già art. 81 TCE), ove è
stabilita la nullità delle intese anticoncorrenziali.
Basti pensare che, secondo
parte della dottrina, la normativa per la tutela della concorrenza e del mercato
dovrebbe addirittura ritenersi incompatibile con l’art. 2596 c.c., secondo quanto
previsto dal meccanismo di incompatibilità previsto dall’art. 15 delle
preleggi, comportando, conseguentemente, l’implicita abrogazione della norma
codicistica.
In base alla normativa
italiana, non ogni convenzione restrittiva della concorrenza è considerata
nulla. La legge italiana n. 287 del 10 ottobre 1990 stabilisce che solo le
intese che impediscono, restringono o falsano in modo significativo il gioco
della concorrenza sul mercato nazionale o in una sua parte rilevante sono
vietate.
Allo stesso modo, l'articolo
101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) dichiara la
nullità degli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra gli
Stati membri e che abbiano lo scopo o l'effetto di impedire, restringere o
falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno.
La disciplina antitrust regola
anche atti che non sono coperti dall’art. 2596 c.c., come le pratiche
concordate e le deliberazioni delle associazioni di imprese. Tuttavia, l’art.
2596 c.c. continua ad applicarsi nei casi in cui il patto, sebbene limiti la
libertà di iniziativa economica e la concorrenza, non soddisfa i requisiti
delle intese e degli accordi vietati. L’art. 2596 c.c. regola anche le
convenzioni che non sono vietate dalle regole antitrust, comprese quelle
che non influenzano i meccanismi economici del mercato. Inoltre, tale articolo
si applica ai patti che, sebbene vietati in linea di principio, presentano
condizioni meritevoli di tutela secondo l’art. 101, paragrafo 3, del TFUE, che
prevede vantaggi sufficienti in termini di efficienza che compensino gli
effetti anticoncorrenziali.
È importante notare che anche
le convenzioni ammesse dalla disciplina antitrust devono essere
stipulate per iscritto come prova, essere circoscritte a una zona o a
un'attività specifica e non durare più di cinque anni. Inoltre, l'applicazione
delle norme del Codice Civile non può essere esclusa dimostrando un effetto
positivo per il mercato.
Le due discipline, antitrust
e Codice Civile, hanno finalità diverse: la prima considera l'impatto
macroeconomico delle intese o degli accordi, mentre la seconda protegge
gli interessi individuali e la libertà negoziale.
Inoltre, è necessario un
cenno alla disciplina che sanziona l’abuso di dipendenza economica. Essa
non si sovrappone a quella dell'articolo 2596 c.c., poiché si occupa di un
fenomeno diverso che può verificarsi attraverso l’imposizione di una
limitazione alla concorrenza. L'abuso di dipendenza economica consiste
nell'imporre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o
discriminatorie secondo la legge del 18 giugno 1998, n. 192. Se la pattuizione integra
un abuso della dipendenza economica, può rappresentare una condizione
ingiustificatamente gravosa e discriminatoria imposta da una parte all’altra
per la conclusione di un contratto. Tuttavia, ciò che è vietato è l’imposizione
dell’accordo attraverso l’abuso, non il contenuto stesso dell'accordo.
Come può evincersi dal quadro
sintetico qui delineato, la disciplina delle limitazioni alla libertà della concorrenza
trova fondamento in una peculiare ed articolata disciplina interna e sovranazionale,
che rende imprescindibile, in sede di negoziazione, la valutazione - caso per
caso - dell’adeguatezza della clausola nonché della sua piena rispondenza ai
canoni di legittimità, validità ed efficacia.